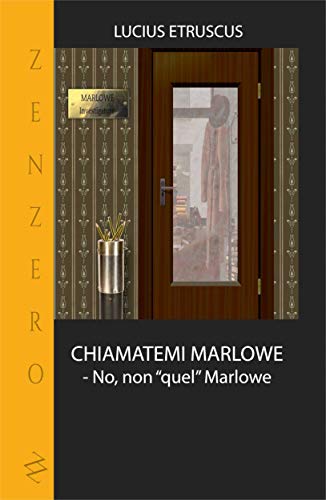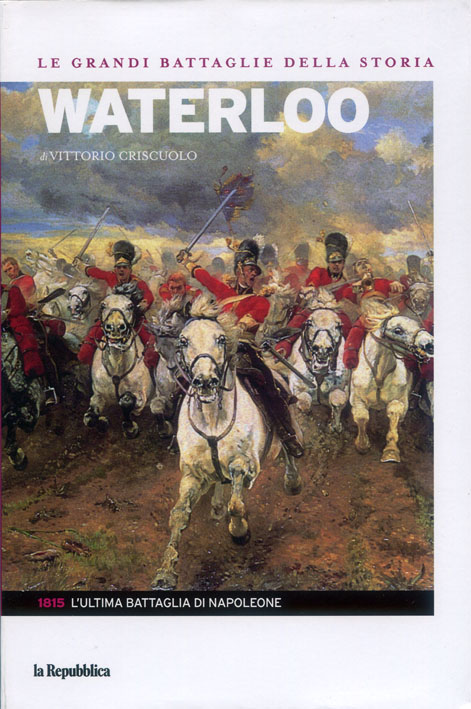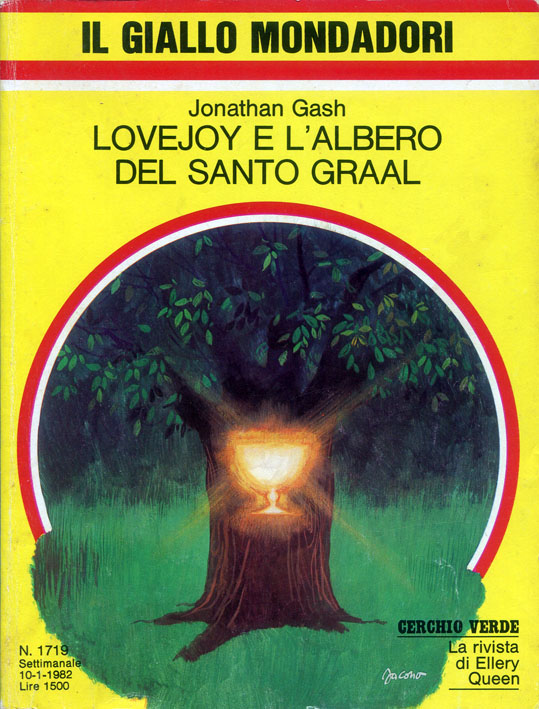Dopo una vita riesco finalmente a raccontare un curioso fenomeno linguistico, nel mio annoso studio della parola zombie.
1. La donna e lo spettro
 Finita la Seconda guerra mondiale, i film americani possono tornare a riempire le sale italiane. Nel luglio 1946 è la volta de “La donna e lo spettro” (The Ghost Breakers, 1940) tratto da uno spettacolo teatrale di Paul Dickey e Charles W. Goddard, «Una specie di doccia scozzese di gelidi spaventi e di calda ilarità», come recita un quotidiano dell’epoca. In pratica sconosciuto nei decenni a venire, la sempre lodevole Sinister Film lo recupera in DVD nel 2012.
Finita la Seconda guerra mondiale, i film americani possono tornare a riempire le sale italiane. Nel luglio 1946 è la volta de “La donna e lo spettro” (The Ghost Breakers, 1940) tratto da uno spettacolo teatrale di Paul Dickey e Charles W. Goddard, «Una specie di doccia scozzese di gelidi spaventi e di calda ilarità», come recita un quotidiano dell’epoca. In pratica sconosciuto nei decenni a venire, la sempre lodevole Sinister Film lo recupera in DVD nel 2012.
Mary Carter (Paulette Goddard) ha ereditato dalla famiglia un “castello maledetto” (così è sempre chiamato) a Black Island, isolotto di Cuba. Partendo alla volta dell’isola si imbatte in Lawrence (Bob Hope), celebrità radiofonica che ha appena rivelato a milioni di ascoltatori le attività criminali di un boss di New York, e per una serie di rocambolesche avventure («Morire è niente, ma odio i preliminari») seguirà la donna fino a Cuba.
Siamo in un’epoca dorata quindi sono tutti ricchi, tranne i cubani, e Mary passa le sere per locali ma poi dovrà andare a visitare questo benedetto… anzi, maledetto castello, intorno al quale ruotano misteriosi interessi che poco importano in questo momento.

Gli eroici ghost breakers
Temo che gli autori stessero pensando ai Caraibi, comunque scopriamo che a Cuba i locali sono dediti a misteriosi culti.
«Ero scettico anch’io, finché non vidi con i miei occhi quelle forze maligne: un prete li chiamerebbe demòni, gli indigeni invece li chiamano vòdo.»
Quel vòdo è la resa del doppiaggio italiano del termine voodoo, che noi oggi pronunciamo vudù.

Black Island, patria del vòdo
Data l’aura paranormale, il comico Bob Hope si presenta ad uno dei personaggi come «cacciatore di spettri» (ghost breakers), l’interlocutore dà segno di non capire l’espressione che dà il titolo al film, segno che non è comune nel linguaggio, come invece diventerà ghost busters dal 1985.

Più che uno zombie sembra un dormiglione
Giunti finalmente al castello, scopriamo lo «zòmbi», pronunciato con la “o” aperta mentre in tempi più recenti si preferisce quella chiusa. «Siamo in pieno vodismo», spiega un personaggio:
«Quando uno muore e viene sepolto pare ci siano dei preti vòdo che hanno il potere di farlo resuscitare. Lo zòmbi non ha una sua volontà. Alle volte lo si vede camminare con gli occhi spenti, eseguendo ordini senza sapere ciò che fa e senza neppure curarsene.»
«Ah, come un tedesco!»
La freddura di Bob Hope esiste solo nel doppiaggio italiano, che all’epoca aveva gioco facile ad associare i tedeschi (cioè nazisti, per estensione popolare) agli zombie, invece in originale la battuta è «You mean like democrats?» Di certo al pubblico italiano importava poco del partito democratico americano dell’epoca.

Uno splendido zombie del 1940
Tutto si risolverà fra gridi e splendide scenografie in bianco e nero, dove Hope e Alex (il suo aiutante nero che fa il “negro”, cioè la parte del servo buono ma sciocco e che parla strano, ruolo per fortuna non sopravvissuto all’epoca) si lanciano in situazioni comiche datate ma perfettamente in linea con i tempi.
Nella sua frizzante biografia semi-seria “They Got Me Covered” (1941), Bob Hope così scrive:
«Abbiamo usato uno Zombie in Ghost Breakers. Uno Zombie non ha pensiero proprio e cammina in giro senza sapere dove vada o cosa stia facendo… Ad Hollywood li chiamano “pedoni”.»
Quante battute si possono fare sul termine? Tante, a quanto pare, ma ciò che conta è che questo film ha conosciuto un rifacimento posteriore, in tempi in cui gli zombie sono decisamente più famosi. Come saranno trattati dalla storia e dal doppiaggio italiano?
2. Morti di paura
 Negli anni Cinquanta l’esplosione inarrestabile di due comici fa venire in mente alla Paramount di avere un film che sembra cucito addosso ai due: perché non lo rifacciamo identico? Nasce così “Morti di paura” (Scared Stiff, 1953) di George Marshall, recuperato in DVD A & R Productions nel 2013. Non è un remake de La donna e lo spettro: è la sua fotocopia, utilizzando le stesse identiche location e lo stesso copione, ma Bob Hope diventa Dean Martin e il servo scemo… Jerry Lewis!
Negli anni Cinquanta l’esplosione inarrestabile di due comici fa venire in mente alla Paramount di avere un film che sembra cucito addosso ai due: perché non lo rifacciamo identico? Nasce così “Morti di paura” (Scared Stiff, 1953) di George Marshall, recuperato in DVD A & R Productions nel 2013. Non è un remake de La donna e lo spettro: è la sua fotocopia, utilizzando le stesse identiche location e lo stesso copione, ma Bob Hope diventa Dean Martin e il servo scemo… Jerry Lewis!
Il doppiaggio italiano nel frattempo si rende conto che non ha senso pronunciare vòdo e così si aggiorna in vùdu, anche se noi oggi di solito diciamo vudù. Così la “o” aperta torna chiusa per zómbi, che però all’inizio Jerry pronuncia con la “p” perché deve fare la battuta: «zómpi: io credevo fosse una danza». In originale credeva fosse un cocktail.
Black Island diventa Isola Nera ma soprattutto cambia la battuta satirica di Bob Hope, secondo cui uno zombie senza volontà era simile ad un democratico: Jerry preferisce «È come un marito».
Il resto del film è identico, scena per scena, battuta per battuta, cambiando giusto qua e là per giustificare le tante canzoni e spettacolini di varietà dei due comici, che sembrano due mattacchioni che si divertono tutto il tempo.

Jerry Lewis che fa l’imitazione di uno zombie
In realtà il 1952 è un periodo burrascoso per Dean Martin e Jerry Lewis, e per avere un’idea dell’aria che tira basti dire che le riprese dovevano cominciare il 31 marzo ma i due non si sono presentati sul set, in pieno “sciopero”. Cinque anni prima hanno firmato un contratto per più di un milione di dollari che sembravano tanti, ma gli stravizi costano e ora non vedono l’ora che il contratto scada per poter alzare la posta, così fanno i capricci. Il Copacabana ha pagato loro più di 30 mila dollari per averli ospiti sul palco durante le riprese del film ma i due continuano i loro capricci: che si riprendano pure i soldi. Jules Podell, direttore del Copacabana, non vuole i soldi, vuole i comici che assicurano il tutto esaurito ogni sera, così fa un esposto all’American Guild of Variety Artists, che chiama i due attori a rapporto per ascoltare i motivi per la loro defezione. Dean e Jerry sono così potenti che se la ridono: che venga la American Guild da loro, se proprio vogliono sentirli.
I capricci funzionano e i due a maggio ricevono un nuovo contratto, ben più ricco – invece di un milione per cinque anni, si vola sul milione l’anno! – così possono iniziare le riprese, nel giugno successivo. Con Dean e Jerry ormai a dieci metri d’altezza rispetto a tutti gli altri.
 La giovane attrice Dorothy Malone, loro co-protagonista, sta vivendo un brutto periodo perché ha appena perso il fratello. Lo sanno tutti sul set, ma quando si presenta con una piccola auto “vissuta”, Jerry Lewis ha la delicatezza di dirle: «Buon Dio, sbarazzati di quel cestino della spazzatura». L’attrice non l’ha presa bene, infatti racconta l’aneddoto – finito nel biografico “Dino. Living high in the dirty business of dreams” (1992) di Nick Tosches – come ad indicare una mancanza di tatto dell’attore, mentre Dean Martin si dimostra molto più delicato e l’aiuta molto sul set.
La giovane attrice Dorothy Malone, loro co-protagonista, sta vivendo un brutto periodo perché ha appena perso il fratello. Lo sanno tutti sul set, ma quando si presenta con una piccola auto “vissuta”, Jerry Lewis ha la delicatezza di dirle: «Buon Dio, sbarazzati di quel cestino della spazzatura». L’attrice non l’ha presa bene, infatti racconta l’aneddoto – finito nel biografico “Dino. Living high in the dirty business of dreams” (1992) di Nick Tosches – come ad indicare una mancanza di tatto dell’attore, mentre Dean Martin si dimostra molto più delicato e l’aiuta molto sul set.
Per capire come lavora il produttore Hal Wallis, autore del successo dei due comici, ci viene in soccorso proprio Jerry Lewis, che nella sua biografia “Dean & Me (A Love Story)” (2005), scritta con James Kaplan, racconta di quando Norman Lear è stato ingaggiato per rimaneggiare la sceneggiatura di Scared Stiff. Essendo un grande fan di Dean Martin, ha cominciato a scrivere scene aggiuntive su di lui e a prendersi molte libertà, finché Hal Wallis – che aveva rifiutato tutte quelle modifiche – lo chiama e gli svela il segreto del successo della coppia comica:
«Un film con Martin e Lewis costa mezzo milione di dollari e ne guadagna automaticamente tre milioni mediante una semplice formula: Jerry è l’idiota, Dean è il gagliardo che canta e si becca la donna. Tutto qua.»
Da ragazzino degli anni Ottanta adoravo questi film – tranne per le noiose canzoni di Dean Martin – quindi posso testimoniare che il sistema funzionava.
L.
– Ultimi post simili:

 Nel 2021 si festeggiano sia i 90 anni del film Dracula (1931) con Bela Lugosi, sia i 35 anni della sua prima apparizione in lingua italiana (il 20 aprile sul mio blog Il Zinefilo), e per l’occasione ho iniziato un viaggio tra i fumetti di “Zagor“, storico eroe della Bonelli che fra i suoi nemici ricorrenti può annoverare Bela Rakosi, un chiaro omaggio tanto al citato film quanto all’attore.
Nel 2021 si festeggiano sia i 90 anni del film Dracula (1931) con Bela Lugosi, sia i 35 anni della sua prima apparizione in lingua italiana (il 20 aprile sul mio blog Il Zinefilo), e per l’occasione ho iniziato un viaggio tra i fumetti di “Zagor“, storico eroe della Bonelli che fra i suoi nemici ricorrenti può annoverare Bela Rakosi, un chiaro omaggio tanto al citato film quanto all’attore.






 Come racconto nel Zinefilo di oggi, il film
Come racconto nel Zinefilo di oggi, il film 

 Con il primo romanzo di una lunga saga, “
Con il primo romanzo di una lunga saga, “ «Io ero un dampiro, metà licantropo e metà vampiro», ribadisce l’autrice in “
«Io ero un dampiro, metà licantropo e metà vampiro», ribadisce l’autrice in “
 Finita la Seconda guerra mondiale, i film americani possono tornare a riempire le sale italiane. Nel luglio 1946 è la volta de “La donna e lo spettro” (The Ghost Breakers, 1940) tratto da uno spettacolo teatrale di Paul Dickey e Charles W. Goddard, «Una specie di doccia scozzese di gelidi spaventi e di calda ilarità», come recita un quotidiano dell’epoca. In pratica sconosciuto nei decenni a venire, la sempre lodevole Sinister Film lo recupera
Finita la Seconda guerra mondiale, i film americani possono tornare a riempire le sale italiane. Nel luglio 1946 è la volta de “La donna e lo spettro” (The Ghost Breakers, 1940) tratto da uno spettacolo teatrale di Paul Dickey e Charles W. Goddard, «Una specie di doccia scozzese di gelidi spaventi e di calda ilarità», come recita un quotidiano dell’epoca. In pratica sconosciuto nei decenni a venire, la sempre lodevole Sinister Film lo recupera 



 Negli anni Cinquanta l’esplosione inarrestabile di due comici fa venire in mente alla Paramount di avere un film che sembra cucito addosso ai due: perché non lo rifacciamo identico? Nasce così “Morti di paura” (Scared Stiff, 1953) di George Marshall, recuperato
Negli anni Cinquanta l’esplosione inarrestabile di due comici fa venire in mente alla Paramount di avere un film che sembra cucito addosso ai due: perché non lo rifacciamo identico? Nasce così “Morti di paura” (Scared Stiff, 1953) di George Marshall, recuperato 
 La giovane attrice Dorothy Malone, loro co-protagonista, sta vivendo un brutto periodo perché ha appena perso il fratello. Lo sanno tutti sul set, ma quando si presenta con una piccola auto “vissuta”, Jerry Lewis ha la delicatezza di dirle: «Buon Dio, sbarazzati di quel cestino della spazzatura». L’attrice non l’ha presa bene, infatti racconta l’aneddoto – finito nel biografico “
La giovane attrice Dorothy Malone, loro co-protagonista, sta vivendo un brutto periodo perché ha appena perso il fratello. Lo sanno tutti sul set, ma quando si presenta con una piccola auto “vissuta”, Jerry Lewis ha la delicatezza di dirle: «Buon Dio, sbarazzati di quel cestino della spazzatura». L’attrice non l’ha presa bene, infatti racconta l’aneddoto – finito nel biografico “


 Mi è capitato di vedere il film Netflix “Vivir dos veces” (2019) della spagnola Maria Ripoll, reso in italiano con “
Mi è capitato di vedere il film Netflix “Vivir dos veces” (2019) della spagnola Maria Ripoll, reso in italiano con “